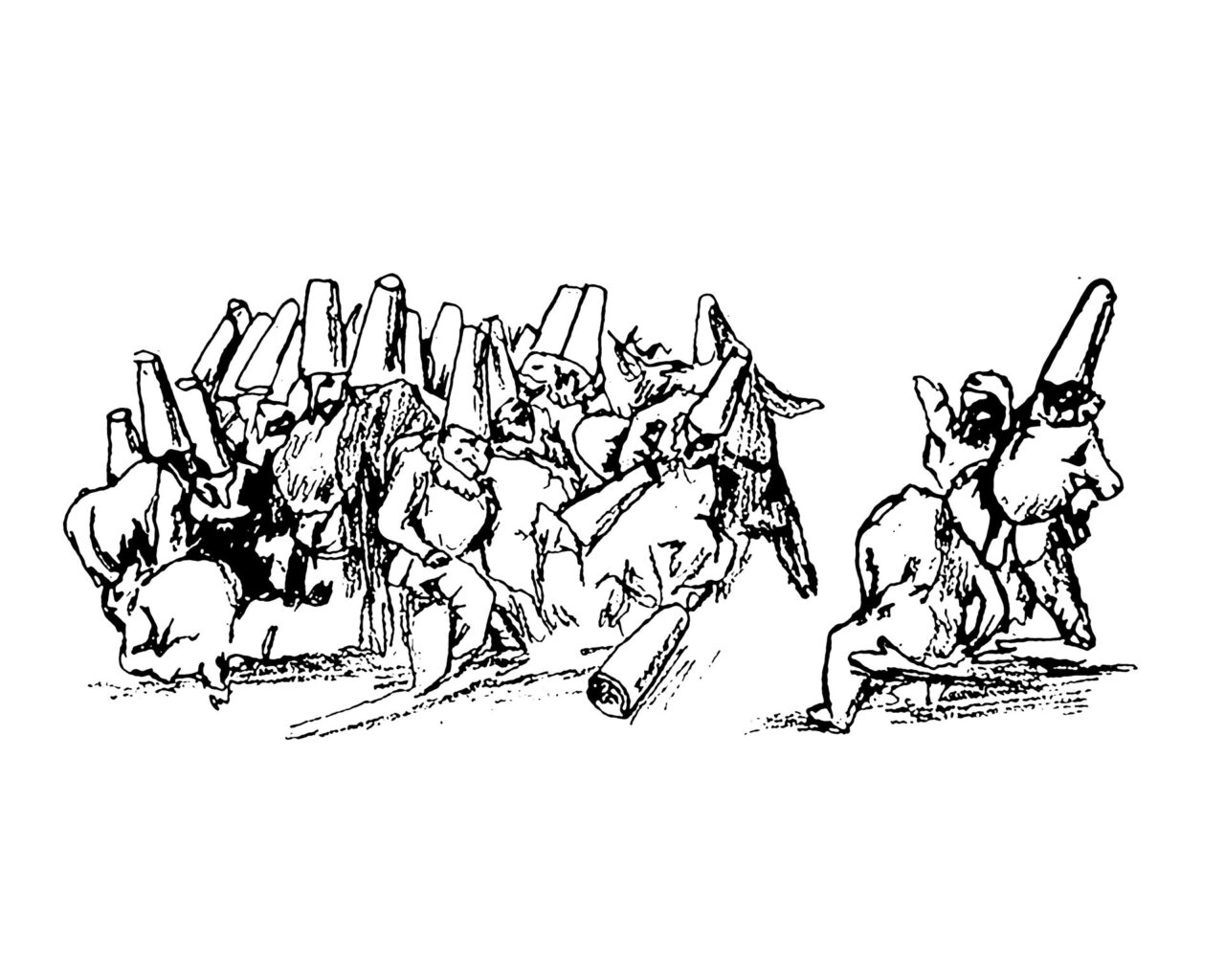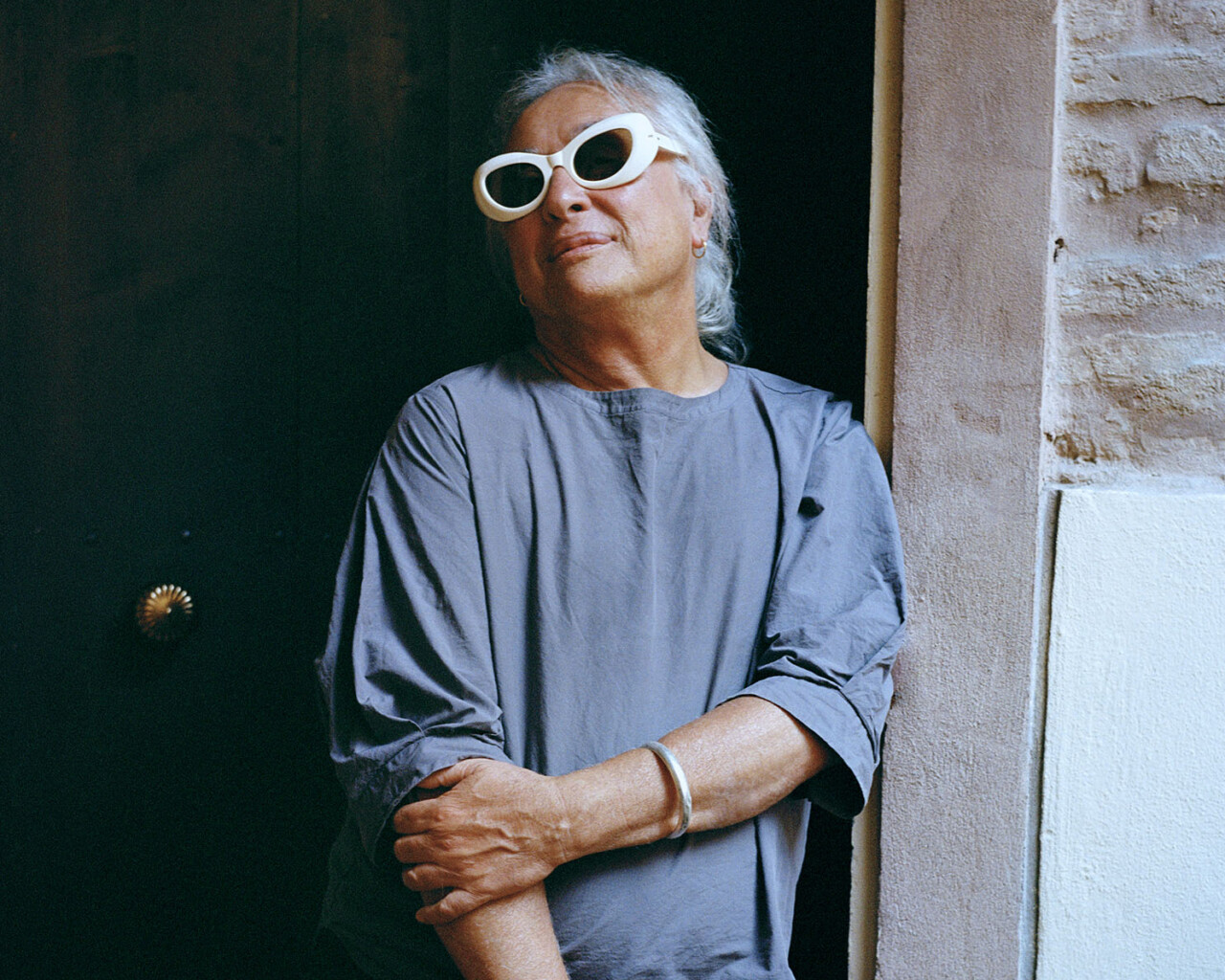NOBODY DIED AT STONEWALL
“We propose that a demonstration be held annually on the last Saturday in June in New York City to commemorate the 1969 spontaneous demonstrations on Christopher Street and this demonstration be called CHRISTOPHER STREET LIBERATION DAY.”
Qualche centinaio, poi più di un migliaio al giorno furono le persone appostate fuori dallo Stonewall Inn, tra la notte del 28 giugno 1969 e le sei successive. Non si sa se quella bottiglia fu lanciata veramente addosso ai poliziotti, o se sia parte del racconto eroico che viene fatto di Stonewall – sicuramente fu abbastanza per far sì che mille persone arrabbiate facessero paura a chi pensava non si sarebbero mai ribellate. Queste qui sopra sono alcune parole della delibera adottata nel novembre del 1969 dal gruppo E.R.C.H.O. (Eastern Regional Conference of Homophile Organizations), in seguito ai moti di Stonewall. Gli organizzatori sognavano una celebrazione di carattere nazionale, che potesse incanalare i sentimenti di orgoglio e autostima degli omosessuali (la sigla LGBT+ non era ancora stata adottata). Chiunque si riconoscesse nel termine omosessuale, non doveva avere timore di nasconderlo. Nelle prime parate pre-Stonewall, c’era addirittura un dress code: sobrio, rigido, che non desse nell’occhio – c’è chi sostiene che dovrebbe ancora essere così. Al contrario, quei corpi che marciavano volevano essere rumorosamente, esplicitamente, orgogliosamente omosessuali.
Lo Stonewall Inn, in Christopher Street, fu il punto di partenza della rivolta. Si trattava di un locale illegale, privo di licenza per la vendita di alcolici, gestito dalla mafia, che vendeva alcolici a prezzi gonfiati. Era perciò soggetto a frequenti retate da parte della polizia. Il bar era frequentato da tante persone LGBTQ+: principalmente uomini gay, ma anche donne lesbiche, drag queen, persone transgender e altre identità di genere non conformi. Il locale faceva parte di un contesto più ampio: il Greenwich Village, un quartiere dove molti giovani queer e transgender vivevano, spesso costretti alla strada dopo essere stati abbandonati o respinti dalle proprie famiglie e dalla società. A un anno di distanza dai moti, la strada che ospitò le rivolte fu di ispirazione per il nome della marcia: Christopher Street Liberation Day. La manifestazione venne così adottata come modello dal mondo occidentale, diventando esempio per le parate successive del Pride.
Le prime Pride Parades degli anni Settanta negli Stati Uniti erano eventi politici autogestiti: niente sponsor, vietato il supporto istituzionale. L’obiettivo principale era ottenere visibilità e rivendicare diritti fondamentali in un contesto di forte discriminazione e marginalizzazione. A partire dagli anni Novanta comparvero i primi sponsor: Absolut Vodka e American Airlines furono tra i primi brand a finanziare i Pride negli US. La parata si trasformò da manifestazione di protesta pubblica a celebrazione istituzionalizzata, segnando un cambiamento nella (auto)narrazione della comunità LGBTQ+.
Negli anni Duemila, il Pride ha subito una trasformazione profonda, segnata dall’ingresso massiccio dei grandi brand. Queste aziende non solo hanno iniziato a sponsorizzare le parate, ma sono diventate veri e propri finanziatori, creando una forte dipendenza economica, oggi difficile (mai impossibile) da spezzare. Parallelamente, il Pride si è popolato di eventi collaterali a pagamento, accessibili solo a chi può permetterseli, lasciando ai margini proprio quelle persone che avevano animato le prime proteste nel 1969. È un’ironia amara: chi ha dato origine al movimento viene oggi, di fatto, escluso da molte delle sue celebrazioni contemporanee. Il modello di Pride sponsorizzato si è rapidamente diffuso a livello globale, ma senza adattarsi alle specificità culturali e sociali di ogni Paese. È stato adottato senza una vera prospettiva internazionale e senza considerare che la consapevolezza (awareness) non equivale all’azione concreta.
Già dagli anni Settanta, alcuni attivisti mettevano in guardia contro la deriva commerciale del Pride, prevedendo il rischio di svuotarlo del suo contenuto politico in favore di un’estetica vendibile e rassicurante. E in effetti, oggi il Pride è diventato un contenitore di rivendicazioni molteplici, tuttavia disgiunte e mal coordinate. La comunità LGBTQ+ non ha mai avuto un’unica agenda compatta: i bisogni sono diversi e frammentati. Dove finiscono, quindi, i soldi dei grandi sponsor? Chi ne beneficia? Le priorità sono tante e cruciali: la homelessness dei giovani queer, spesso cacciati di casa dalle famiglie; l’accesso a terapie di affermazione di genere e cure mediche adeguate; lo stigma ancora radicato sull’HIV; la terapia ormonale per i minorenni, oggetto di dibattiti accesi e politicamente strumentalizzati; i crimini d’odio; le difficoltà nel sistema giudiziario e nel mondo del lavoro, dove le discriminazioni sono ancora sistemiche. Queste battaglie convivono, ma raramente vengono affrontate in modo unitario.
Negli anni Ottanta, gli uomini gay hanno dovuto lottare contro lo stigma dell’HIV, e proprio questo ha probabilmente plasmato il modo in cui le rivendicazioni LGBTQ+ sono state veicolate. Sono comodi capri espiatori: ieri le persone sieropositive, oggi le persone transgender e l’“ideologia gender”, diventati bersagli prediletti nei discorsi politici, come dimostrano le campagne d’odio portate avanti da Donald Trump e dagli esponenti conservatori. Nel contesto odierno, facente occhiolino alla destra globale, è evidente come molte delle dichiarazioni di supporto al Pride da parte delle aziende e delle istituzioni si rivelino vuote, prive di impatto nella vita quotidiana delle persone LGBTQ+. Sono claim di facciata, facilmente smentiti dalla realtà dei fatti, confezionati per assicurarsi un nuovo, intercambiabile segmento di mercato. È necessario diffidare di chi offre tanto e pretende il doppio. Il Pride ne esce depotenziato, e sempre più distante da chi continua a lottare. Forse è davvero il momento di ripensare a chi viene realmente incluso, chi resta fuori, e soprattutto: chi ne trae davvero beneficio.
La mancata prospettiva intersezionale ha prodotto una reazione a catena importante: le aziende che finanziano il Pride, e ci lucrano, assumono posizioni superficiali, riducendo il loro coinvolgimento a slogan o campagne pubblicitarie stagionali. Tuttavia, questa superficialità non riguarda solo il mondo corporate. Anche il popolo, sia interno che esterno alla comunità LGBTQ+, è spesso complice di questa narrazione semplificata, mostrando scarso interesse ad approfondire le complessità e le contraddizioni del movimento. Quando il Pride diventa una festa accessibile solo a chi è già integrato o economicamente privilegiato, senza spazio reale per chi vive marginalità multiple, la risposta inevitabile è la nascita di marce e parate parallele. Questi eventi autogestiti si sono dati una chiara identità: sono gli anti-Pride (per esempio, la nostra Marciona milanese), proprio per marcare la distanza da un Pride istituzionalizzato, sponsorizzato e svuotato della sua originaria forza politica. Queste parate alternative rifiutano il modello commerciale, rivendicano spazi radicali e più inclusivi e riportano al centro temi scomodi, troppo spesso ignorati nei grandi eventi ufficiali: il razzismo sistemico, la transfobia, la povertà queer, la violenza istituzionale. In fondo, il rischio più grande per il Pride non è la sponsorizzazione in sé, ma la perdita della memoria storica. Quando l’intersezionalità viene ignorata, non solo si escludono persone e battaglie, ma si alimenta un movimento che smette di essere collettivo per diventare un prodotto di consumo.
Amiamo quando le cose falliscono, soprattutto quando sono nate da nobili intenti come la lotta per i diritti civili. C’è una sorta di Schadenfreude collettiva, una soddisfazione maliziosa che attraversa tanto chi è stato deluso dal Pride quanto chi non lo ha mai sostenuto, nemmeno quando era una moda.
I social sono invasi da video dal titolo provocatorio e compiaciuto, come «Pride Month Fell Off (and I’m Glad)» della YouTuber SmugAlana o «The Downfall of ‘Pride’ Is Here and It’s Glorious» di Matt Walsh. Nel video «The Downfall of Pride Month», pubblicato su YouTube a giugno 2025, Misha Petrov prende di mira proprio le manifestazioni considerate “caricaturali” dell’orgoglio LGBTQ+, accusando, servendosi di commenti omofotransfobici e TERFemministi, alcune persone di essere «troppo LGBT» e ridicolizzando chi condivide le proprie esperienze di emarginazione tramite contenuti social definiti cringe.
In questo clima, da entrambe le parti – sia tra chi vorrebbe un Pride più radicale, sia tra chi non ne vorrebbe proprio uno – prevalgono la confusione, il risentimento e una diffusa stanchezza. Ma forse il problema non è solo nel Pride, quanto in come ci siamo abituati a consumare il fallimento degli altri come intrattenimento.
Sto scrivendo questo articolo il 28 giugno 2025, cinque ore prima del Milano Pride, a cui parteciperò entusiasta, nonostante le mie riserve critiche anti-capitale. Non dobbiamo accettare un modello di Pride esportato, eurocentrico, mancante di profondità e prospettiva. Tuttavia il cinismo non è la risposta: non risolverà le contraddizioni, non guarirà le ferite della comunità, e soprattutto non costruirà nulla. Serve responsabilità e, ancora, la voglia di prendersi cura. Dobbiamo imparare a indirizzare insieme la nostra rabbia, trasformandola in immaginazione politica, in capacità collettiva di pensare e costruire un mondo diverso.
· · ·
Nettuno Battisti, divinità marittima di professione, paroliere per predilezione. Zigzaga tra queerness e semiotica. Dopo la laurea in comunicazione segue rotte inspiegabili, mentre medita silenziosamente la sua prossima mossa.