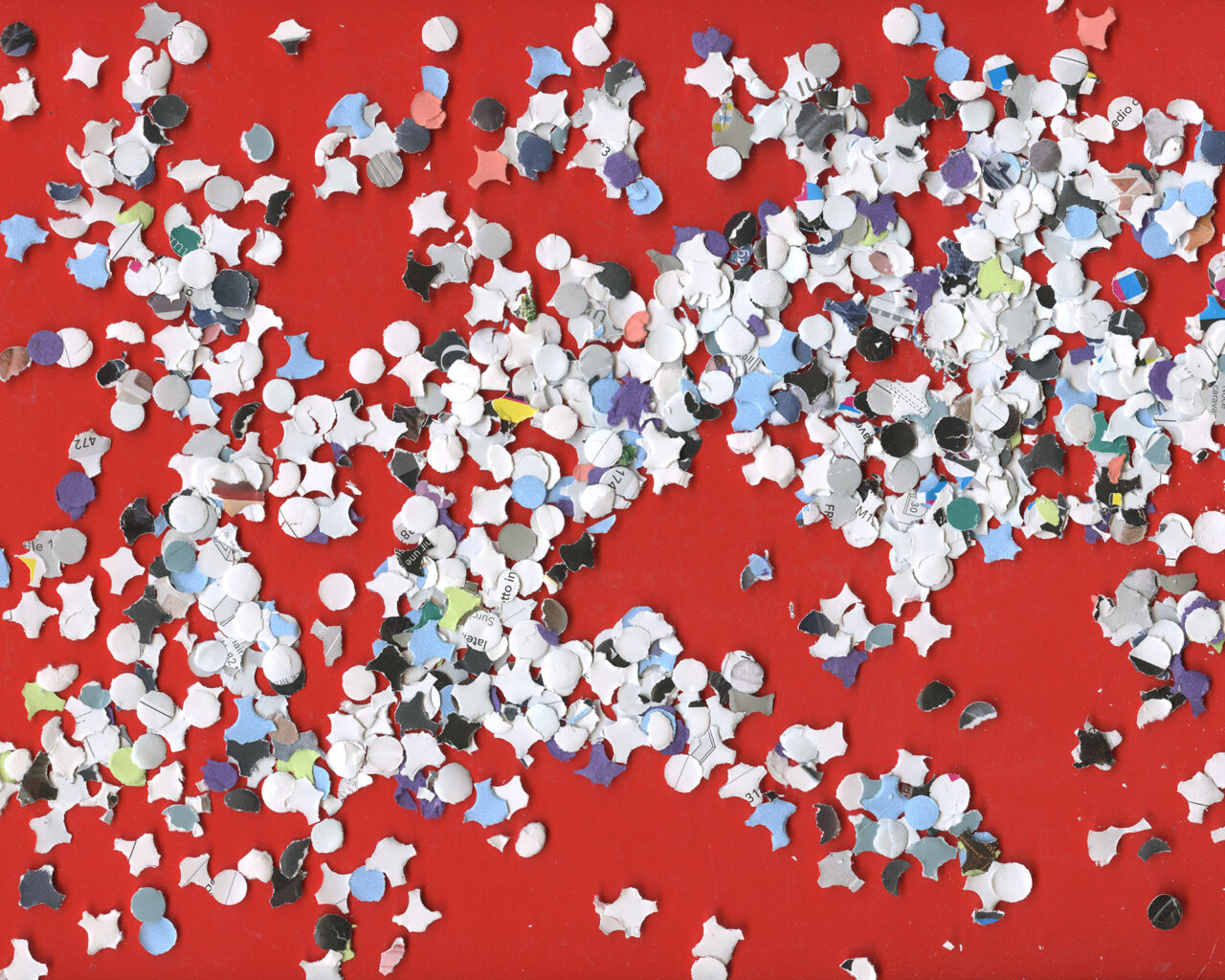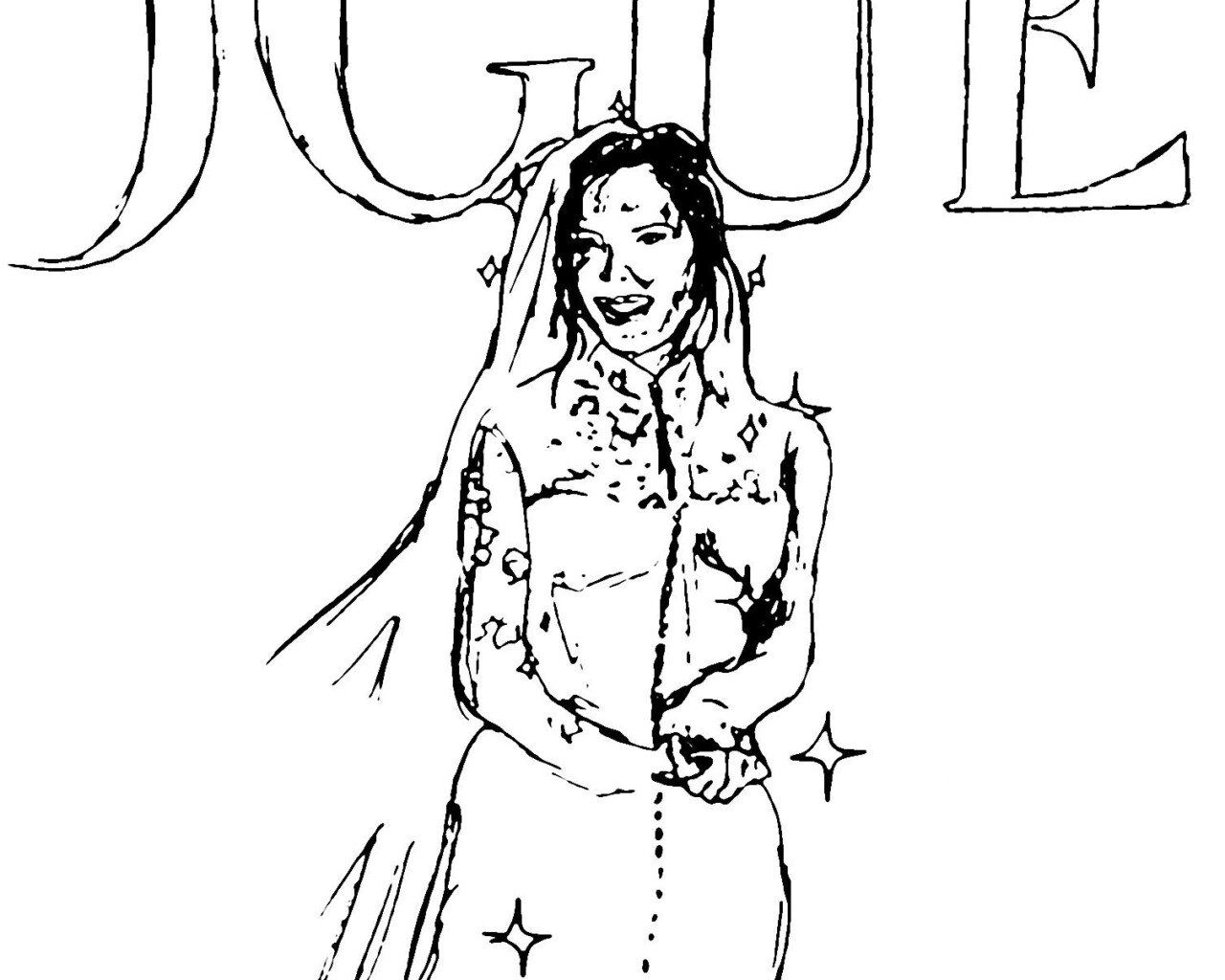Smemorat*
“Durante il riposo vengono a trovarci alcuni pastori. È gente che non si sa di dove sia sbucata e che cosa voglia. Si siedono intorno a noi, cominciano a toccare tutti gli oggetti che abbiamo, cercando di rovistare anche in tasca. Mi ricordo delle meraviglie suscitate in loro dai cerini e dalla mia pipa corta: dinanzi agli strumenti topografici rimasero intontiti. Povera gente primitiva! Fino allora non ci eravamo mai imbattuti in gente più primitiva; credo che essi vivessero la vita di duemila anni fa!”
Così scriveva, nel 1917, Antonio Baldacci raccontando di un viaggio in Albania che fece vent’anni prima per la Società Geografica Italiana. Botanico, geografo e etnografo Baldacci fu solo uno dei tanti viaggiatori mandati dall’Italia ad esplorare regioni delle quali non vi erano informazioni di prima mano e, soprattutto, sulle quali l’Italia aveva mire espansionistiche. La produzione di questo tipo di conoscenze, veicolata per lo più tramite associazioni geografiche, era atta ad anticipare un tentativo di espansione politico militare verso quel dato territorio ed era una prassi comune tra potenze occidentali del XIX secolo. Baldacci, quando descrive questo aneddoto, era nel pieno di una spedizione esplorativa del nord dell’Albania, a quell’epoca controllata dal morente impero Ottomano, trovandosi a dover interagire con un gruppo di pastori locali iniziò a descriverne gli atteggiamenti e le interazioni che lui ed il suo gruppo ebbero con loro. L’autore descrive questo incontro tramite la temporalità, proietta nel suo resoconto queste persone come appartenenti ad un universo temporale primitivo quindi diverso dal suo. Lo scopo della presenza di Baldacci in quel luogo è la descrizione dello spazio e di ciò che lo abita, la modalità tramite la quale egli cerca di restituire un’idea dello spazio è configurando il tempo che queste persone – secondo lui – stavano vivendo come diverso dal suo e da quello delle persone che leggeranno il suo resoconto. L’incontro con l’alterità locale assume così i connotati di un racconto sci – fi dove l’autore, viaggiando nel tempo, si trova improvvisamente a contatto con dei primitivi nonostante lo scopo scientifico della pubblicazione.
La descrizione dell’altro, non solo come individuo o gruppi di persone ma anche come spazio, tramite canoni temporali è un fenomeno comune in questa letteratura – etnografica e/o antropologica – prodotta a cavallo tra i due secoli in Europa. Baldacci si inserisce a pieno titolo nelle produzioni letterarie che hanno trattato l’incontro con l’alterità a fini scientifici e/o divulgativi in quel periodo. In poche parole, la narrazione dell’altro, inteso come realtà sociale abitante uno spazio altro, tramite una sua collocazione temporale può essere considerato un discorso collettivo condiviso e ripetuto all’interno della cultura occidentale. Questo discorso è stato studiato ed identificato dall’antropologo Johannes Fabian che ne ha costruito una parziale fenomenologia nel testo ‘The time and the Other: How Anthropology Makes its Object’ uscito nel 1983. L’autore analizza le modalità attraverso le quali la temporalità viene usata per descrivere l’alterità spaziale, giungendo alla conclusione che quest’associazione spazio-tempo riflette la necessità di creare una distanza tra chi narra e chi viene narrato. A proposito di tale necessità è opportuno sottolineare, in questo contesto, come fosse frutto di processi culturali e narrativi di lunga durata che trovarono il loro punto di svolta nell’esperienza illuminista. In secondo luogo, essa si fonda sul metodo comparativo che, tramite la creazione di determinati parametri compie una valutazione della realtà narrata.
Stabilito che, alla base di questo fenomeno, vi è la necessità di creare una distanza tra la forza produttrice del discorso ed il soggetto narrato è opportuno interrogarsi su come venga stabilita questa distanza. Fabian individua nel riconoscimento di vivere nello stesso tempo, nella stessa tempo-linea, da parte di chi scrive nei confronti di chi è raccontato il primo segmento verso una comunicazione paritaria. Io, narrante, riconosco te, narrato, come appartenente se non alla mia società almeno al mio stesso contesto temporale e sulla base di ciò la comunicazione e la conseguente rappresentazione possono tenersi su un livello paritario. Quando chi produce la narrazione percepisce la società di cui fa parte, con la sua memoria immanente, in una posizione temporale diversa rispetto a quella della realtà che vuole raccontare si crea una distanza incolmabile fondata sulla temporalità. La creazione di questa distanza viene identificata come ‘negazione della contemporaneità’, espressione coniata dallo stesso Fabian (‘Negation of Coevalness’). Tramite questa negazione il narrato viene ancorato dal narrante ad un passato predeterminato che gli impedisce di collocarsi nella medesimo punto del narrante. La negazione della contemporaneità diventa uno strumento fondamentale per una rappresentazione dell’alterità all’interno della cultura occidentale. Tale negazione rientra in un sistema di pratiche organizzate dal punto di vista culturale ed economico utilizzate per identificare e creare uno spazio diseguale nel quale intrecciare i rapporti con l’altro. Queste pratiche sono multiformi e molte di esse operano ancora oggi nella rappresentazione del mondo, quello che interessa in questo contesto però è analizzare un poco più approfonditamente il ruolo della temporalità all’interno di tali rappresentazioni, individuando come tale rappresentazione della temporalità comporti una visione diseguale della storia e come questa visione si rifletta, ancora oggi, sul nostro spazio pubblico.
Per fare ciò è opportuno riflettere sulla figura del produttore del discorso e le operazioni che esegue per negare la contemporaneità all’alterità. Chi scrive dell’altro compie, indirettamente, una comparazione tra la sua memoria storica come individuo prodotto di una specifica esperienza sociale, politica e culturale, e la memoria dell’individuo altro rispetto a quest’esperienza storica. Concludendo, indirettamente, come la sua memoria di narrante sia più ricca ed articolata rispetto a quella dell’altro, vista come più povera di avvenimenti ed esperienze spesso identificata, come si vede nella citazione, come primitiva, prima di progresso. Compiendo quest’operazione e presentando, nella produzione letteraria e culturale, il risultato di questa comparazione chi narra non solo crea una distanza colmabile solo con millenni di esperienza storica tra sé e l’altro ma impone anche la propria esperienza temporale come paradigmatica, svolgendo una funzione di ordinamento. Chi scrive, in breve, propone una prospettiva sull’alterità che non solo spiega sé stessa ma è anche in grado di contenere l’alterità e spiegarla secondo i propri canoni. Quest’operazione ci porta a riflettere su un dato fondamentale: se abbiamo una produzione culturale che tende ad inserire l’alterità nella propria concezione del tempo e della storia vuol dire che l’alterità ha, almeno a livello di cultura, narrazione, discorso e percezione una propria temporalità e che, di conseguenza, esistano temporalità multiple che la nostra concezione storica non riflette appieno.
Comprendendo la temporalità come fenomeno capace di pluralità e non appiattito su un’unica percezione è naturale notare come la storia, per come la conosciamo nella sua narrazione pubblica e collettiva, raramente rifletta questa pluralità. L’esistenza della temporalità come un fenomeno multiplo e diverso, non allineabile su un’unica tempo-linea va però riconosciuta e ribadita e come farlo non è un problema di facile soluzione. La storiografia tradizionale, come nota Russel West-Pavlov in ‘Temporalities’ (2012), basandosi su una serie di valori specifici per spiegare il mondo ha escluso metodologicamente l’esistenza di altre temporalità, proponendo sé stessa come unica interprete della realtà. La nostra conoscenza storica, non a livello accademico, ma a livello istituzionale e pubblico sembra essere ancora in buona parte basata su concezioni formatesi grazie allo storicismo. Lo storicismo fu una corrente storico-filosofica complessa e difficilmente riassumibile in poche parole. In questo contesto è bene però notare come lo storicismo si fondi su un’idea lineare della storia, strettamente legata allo sviluppo dell’idea di Stato-Nazione, capace di avvallare un’idea deterministica e sequenziale dello scorrere temporale e storico sublimata nella figura della linea del tempo, ancora oggi strutturale nell’apprendimento della storia nelle scuole primarie. L’utilizzo di questa logica nella narrazione storica favorisce la creazione di un’unica storia, un’unica linea temporale nella quale vengono collocate, più avanti o più indietro a seconda di parametri autoreferenziali, entità altre produttrici della propria memoria storica difficilmente collocabili in questa concezione del tempo. Come un tale discorso temporale possa essere messo in discussione, nonostante sia radicato così in profondità nella nostra conoscenza collettiva, è un problema fondamentale che si pone oggi. A tale proposito bisogna fare alcune annotazioni sugli sviluppi del sapere storico a livello accademico. Il modello storicista prese il sopravvento nel ‘800 rimanendo egemone, anche nell’accademia, fino circa gli anni ‘60/’70 del ‘900 quando con l’allentarsi della presa imperialista del mondo occidentale sul resto del pianeta, anche le strutture di produzione del sapere coloniale iniziarono a venire discusse in modo sistematico. La produzione del sapere storico fu una delle prime a venire messa in discussione. Come notò Edward Said, lo storicismo, e fenomeni ad esso appartenenti come l’orientalismo, iniziarono ad essere percepiti e studiati come discorsi atti ad utilizzare una storia umana per raccontare la storia dell’umanità intera. A questa apertura seguono processi di critica strutturali, dove viene evidenziato come i modelli europei di storia e di tempo siano stati imposti globalmente tramite l’utilizzo di concetti vettoriali, come quello di ‘progresso’, atti a legittimare l’universalismo di una determinata concezione del tempo. Per esempio, è il progresso occidentale, rappresentato dalla pipa e dai cerini, che Baldacci utilizza per etichettare e mappare la realtà circostante come primitiva. L’imposizione globale della nostra storia, tramite questi concetti, ha creato le condizioni per le quali la collettività nella quale noi, diretti discendenti di chi ha prodotto tale concetto di storia – ossia dei maschi, bianchi, cis – viviamo è, per lo più, inconsapevole di vivere nella propria egemonia temporale, dell’esistenza di altre storie fuori da essa e del privilegio che questo determina. Se nel mondo accademico questa concezione del tempo e della storia è ormai chiaramente riconosciuta come tale e le concezioni storiciste stanno venendo progressivamente abbandonate, nel discorso e nello spazio pubblico ed istituzionale questa concezione rimane egemone. Questa egemonia è evidente soprattutto nella monumentalizzazione di una determinata storia, fenomeno diventato attualissimo negli ultimi due anni e che si spera rimanga per molto tempo.
La dimensione del monumento, in quest’analisi, è cruciale perché una storia che diventa monumento in uno spazio pubblico inizia a svolgere una funzione identitaria. In un mondo nel quale la storia viene ancora vista generalmente come unica ed unidirezionale il monumento diventa espressione di quella data temporalità e di quella data storia. In poche parole, il monumento rientra nella logica che vede l’affermarsi di una data storicità egemone, rientrante a pieno titolo in quella forma di potere che Gramsci individuò come egemonia culturale. Il concetto di egemonia culturale ha avuto interpretazioni varie nel corso degli studi su Gramsci, in questo ambito è bene ricordare il lato strutturale, in senso marxista, che ha questo concetto per capirne l’importanza. L’egemonia è, in prima istanza, un riflesso dei rapporti di forza all’interno del sistema di produzione e, su questi rapporti di forza, si basa il prestigio degli intellettuali cosiddetti organici che promuovono l’egemonia sociale e culturale di un determinato gruppo. In sostanza, l’egemonia non va intesa come solamente culturale ma come uno specchio dei rapporti di forza. Così come lo storicismo è nato in funzione di una visione imperialista del mondo che vedesse le nazioni europee come più progredite rispetto a ciò che le circondava, così oggi il senso egemone della storia, sublimato dall’esistenza da vari monumenti, non è rappresentativo delle classi sistematicamente sfruttate all’interno del sistema capitalistico borghese ad oggi predominante.
Cercando di tirare le fila di questa riflessione teorica, si potrebbe dire che la memoria che i monumenti raccontano è la memoria di uno specifico gruppo il quale ha costruito la propria egemonia prima nell’ambito dei rapporti di produzione e poi nella sfera culturale del discorso pubblico. Questa memoria, va da sé, non può né essere unica né occupare gli spazi di altre storie e di altre memorie però è esattamente quello che succede nelle nostre città. I monumenti ci raccontano non una storia oggettiva ma una storia ed una memoria soggettive ambendo però alla loro oggettività. Per esempio la statua di Edward Colston a Bristol presentava un commerciante di schiavi e filantropo come una persona al quale dedicare un monumento celebrativo. Quella statua diceva ai fruitori che Colston era parte dell’identità della città di Bristol. Va da sé che la celebrazione di questo personaggio come rappresentativo dell’identità comporta in sé una violenza strutturale, impone la memoria di chi non ha subito soprusi dalla tratta degli schiavi a chi li ha subiti ed oggi abita quello spazio urbano. Gettare quella statua nel fiume non significa cancellare Colston dalla storia della città, i libri di storia sono ricchissimi di personaggi storici che non hanno un monumento a loro dedicato, spesso proprio perché difficilmente celebrabili a causa di ciò che hanno fatto in vita, ma che non vengono dimenticati, anzi vengono studiati, la ricerca su di loro e sul loro ruolo nel formare strutture ed identità continua senza soluzione di continuità. Ciò che viene discusso tramite questo gesto sono la memoria e l’identità che queste statue vogliono affermare nella contemporaneità. Questo gesto è dire come l’identità contemporanea di una città con diverse anime, diverse forme culturali e diverse temporalità non possa essere più rappresentata da uno schiavista.
Il rapporto distruttivo con le statue rappresentanti una memoria di classe, egemone ed esclusiva è paradigmatico del funzionamento di queste meccaniche e del conseguente discorso di potere implicato in esse. Davanti a tali dinamiche sembra naturale come una società civile matura abbia al suo interno frange di dissenso nei confronti di queste statue e della memoria che esse normalizzano. Nella maggior parte dei casi, la memoria rappresentata dalle statue in discussione rientra in quel discorso di egemonia culturale prima delineato, ossia rappresenta anche una storia derivata dai rapporti di forza all’interno della società e del sistema nel quale siamo inseriti. Non è un caso che il rapporto conflittuale con questi simboli venga costantemente rivendicato da collettività che vengono sfruttate in modo strutturale all’interno della nostra società, a partire dalle donne arrivando fino alle collettività escluse strutturalmente dal benessere su base razziale. Non è neanche un caso che, ad ogni episodio, ad ogni tentativo di ridiscutere il significato della memoria presente nello spazio pubblico vi sia una serie di giornalisti, scrittori ed intellettuali organici, nella definizione gramsciana, che costantemente si schierano a favore dell’inviolabilità ed indiscutibilità della memoria rappresentata.
In conclusione, le statue sono solo un esempio del funzionamento di certe dinamiche, davanti alla messa in discussione di un certo tipo di memoria da parte di chi non è produttore di una cultura egemone, si assiste ad una levata di scudi unica, generalmente fatta da intellettuali, o presunti tali, maschi bianchi che ribadiscono la necessarietà di una tale memoria. Ora è superfluo notare come una tale memoria sia riflesso di uno sfruttamento economico e sociale verso la classe che questa memoria non può sentirla propria, ed è quindi anche superfluo notare come la lotta nell’ambito dei monumenti e della memoria non sia scollegata dalle lotte per i diritti sociali. Va da sé quindi che questa lotta per lo spazio pubblico e la memoria collettiva vada continuata, perché rappresentazione e struttura in senso marxista rimangono intimamente ed indissolubilmente collegate, la giustizia sociale passa anche da queste battaglie ed è metodologicamente ed eticamente corretto sostenerle, sempre.
Breve bibliografia:
Baldacci, Antonio. Itinerari Albanesi. Roma: Reale Società Geografica Italiana, 1917.
Fabian, Johannes. Time and the Other, How anthropology makes its object. New York: Columbia university press, 1983.
Said, Edward W. Orientalism. New York: Random House Inc., 1978.
West – Pavlov, Russel. Temporalities. New York: Routledge, 2012.
Young, Robert J. C. White Mythologies. 2Nd ed. Abingdon: Routledge, 2004.
· · ·
Pietro Dalmazzo ha studiato storia presso l’Università di Bologna. Vive in Inghilterra dove è dottorando in Italian Studies presso l’Università di Durham con un progetto di ricerca a proposito dell’imperialismo culturale italiano nei Balcani durante il Fascismo.
Fotografia di Alessandro Merlo